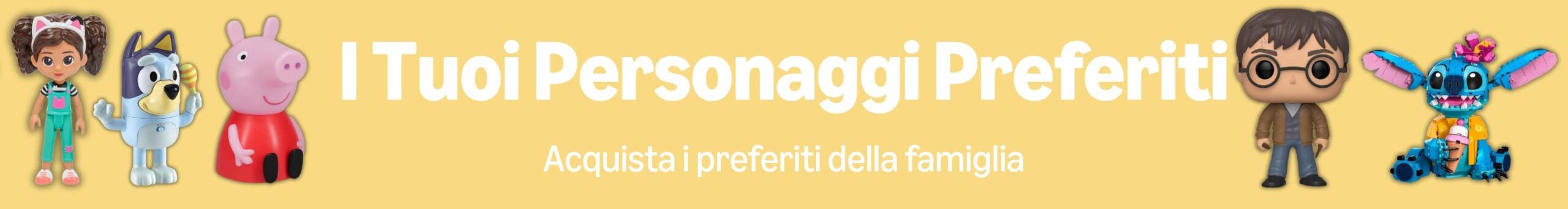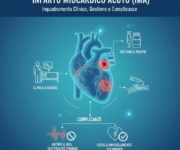Lo shock anafilattico rappresenta un’emergenza medica tempo-dipendente e potenzialmente fatale. La comprensione strategica e immediata del suo meccanismo fisiopatologico è fondamentale per un intervento clinico efficace, in grado di prevenire esiti avversi. Definito come una forma di shock distributivo, è caratterizzato da un’insorgenza estremamente rapida, che si manifesta in pochi secondi o minuti dall’esposizione ad un antigene scatenante.
La criticità di questa condizione è sottolineata dalle tre principali cause che conducono all’esito fatale:
- arresto cardiaco improvviso;
- shock distributivo;
- asfissia, secondaria all’edema laringeo.
Dal punto di vista eziologico, è cruciale una distinzione tra la reazione anafilattica e quella anafilattoide. La prima è una reazione immunologica IgE-mediata, che richiede una precedente fase di sensibilizzazione all’antigene. La seconda, invece, non è IgE-mediata e non necessita di una sensibilizzazione pregressa. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la differenza nel meccanismo di attivazione, le due reazioni sono clinicamente indistinguibili e richiedono il medesimo approccio terapeutico d’urgenza.
Questa distinzione, sebbene importante a livello fisiopatologico, non modifica la gestione clinica, che deve invece focalizzarsi sull’identificazione dei potenziali fattori scatenanti per orientare la diagnosi e la prevenzione.
Eziologia e fattori scatenanti
Now loading…
Il riconoscimento dei potenziali agenti eziologici è un passaggio clinico di primaria importanza. Esso non solo guida la diagnosi differenziale nel contesto acuto, ma è indispensabile per la gestione immediata (es. allontanamento dall’allergene) e per impostare strategie di prevenzione a lungo termine per il paziente. Gli agenti scatenanti possono essere catalogati in diverse macro-categorie.
- farmaci:
- cefalosporine e penicilline;
- sulfamidici e tetracicline;
- antisieri e vaccini;
- anestetici locali;
- ormoni;
- miorilassanti;
- alimenti:
- pesci e crostacei;
- uova;
- arachidi;
- cioccolato;
- altre cause:
- pollini;
- funghi;
- elminti;
- veleno di serpenti o imenotteri;
- lattice.
L’identificazione di questi agenti è il primo passo per interpretare correttamente la vasta gamma di manifestazioni cliniche che possono provocare, la cui gravità deve essere attentamente classificata.
Classificazione della gravità e quadri clinici
La stratificazione della gravità della reazione è un passaggio diagnostico cruciale, poiché determina direttamente l’aggressività e la tipologia dell’intervento terapeutico da attuare. Le manifestazioni cliniche possono variare da forme lievi a quadri di shock conclamato. Si identificano tre principali categorie di gravità.
- Reazioni allergiche lievi
Queste reazioni presentano una manifestazione prevalentemente cutanea e gastrointestinale. I segni tipici includono eritema diffuso e prurito generalizzato, che possono essere talvolta associati a diarrea e/o dolori addominali. In questa fase, non vi è compromissione né respiratoria né emodinamica. - Reazioni anafilattiche con compromissione respiratoria
Questo quadro clinico rappresenta un’evoluzione peggiorativa, in cui ai segni cutanei e gastrointestinali si aggiungono sintomi respiratori critici. Tra questi figurano raucedine, disfagia e dispnea, quest’ultima spesso manifestata con una sensazione di “nodo alla gola” dovuta all’edema a livello delle corde vocali. Possono inoltre essere presenti broncospasmo e rantoli polmonari. Tali reazioni meritano particolare attenzione in quanto possono compromettere seriamente la funzionalità respiratoria e potenzialmente evolvere verso l’arresto cardiorespiratorio. - Shock anafilattico conclamato
È la forma più grave, caratterizzata da una severa compromissione dell’emodinamica. La causa è una vasoplegia sistemica, indotta dalla liberazione massiva di IgE da parte dei mastociti sensibilizzati. I segni cardine di questo stato sono tachicardia, ipotensione severa e un’aumentata sudorazione.
La possibile sovrapposizione di questi quadri clinici con altre patologie acute rende essenziale un’accurata e rapida diagnosi differenziale.
Approccio diagnostico e diagnosi differenziale
In un contesto di emergenza, la capacità di distinguere lo shock anafilattico da altre patologie acute che possono mimarne la sintomatologia è di vitale importanza. Patologie cardiache e respiratorie acute, infatti, possono presentarsi con un quadro clinico simile, rendendo la diagnosi differenziale un passaggio critico.
Gli strumenti fondamentali per orientare la diagnosi sono i dati anamnestici, ricercando una possibile esposizione a un allergene noto o potenziale, e i dati clinici emersi dall’esame obiettivo. È necessario escludere attivamente altre condizioni potenzialmente fatali.
| Patologie respiratorie | Patologie cardiache |
|---|---|
| Edema polmonare acuto | Infarto Miocardico Acuto (IMA) |
| Tromboembolia polmonare | Tachiaritmie |
| Pneumotorace | |
| Aspirazione di corpo estraneo | |
| Epiglottite |
Una volta posta la diagnosi di anafilassi, il focus deve spostarsi immediatamente sulla gestione terapeutica, modulata in base alla gravità del quadro clinico.
Strategie terapeutiche e gestione clinica
L’approccio terapeutico allo shock anafilattico deve essere scalare e commisurato alla gravità della reazione, seguendo le linee guida consolidate e la pratica clinica d’urgenza. La gestione si diversifica in modo sostanziale a seconda dello stato clinico del paziente al momento della valutazione.
Nel caso in cui il paziente si presenti in arresto cardiaco, il protocollo standard prevede l’immediato avvio delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP), associate a infusione di liquidi e adrenalina. Se il ritmo cardiaco è defibrillabile, si procede con la defibrillazione.
Se il paziente non è in arresto, è fondamentale distinguere la gravità della reazione per scegliere il trattamento più appropriato.

Trattamento delle reazioni lievi: in assenza di compromissione respiratoria e/o emodinamica, la somministrazione di un antistaminico in associazione a un cortisonico è considerata una terapia sufficiente a controllare la sintomatologia.
Trattamento delle reazioni gravi (con compromissione respiratoria e/o emodinamica): in presenza di sintomi respiratori (dispnea, nodo alla gola) o emodinamici (ipotensione severa), il farmaco di prima linea è l’adrenalina, come indicato dalle linee guida dell’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology).
Via di somministrazione e dosaggio: la via di somministrazione raccomandata è quella intramuscolare, alla dose per il paziente adulto di 10 microgrammi/kg, fino a un massimo di 500 microgrammi. In ambiente ospedaliero, personale esperto può somministrarla per via endovenosa a boli refratti da 50 microgrammi.
Meccanismo d'azione: l'efficacia dell'adrenalina è legata ai suoi molteplici effetti farmacologici: riduce la vasodilatazione e l'edema laringeo, induce broncodilatazione, esercita un'azione inotropa positiva sul miocardio e diminuisce il rilascio di istamina e leucotrieni.
In presenza di un broncospasmo importante, è indicata la somministrazione di un beta2-agonista come il salbutamolo. Una considerazione particolare va riservata ai pazienti in terapia cronica con beta-bloccanti: in questi soggetti, l’efficacia dell’adrenalina può risultare diminuita, rendendo necessario considerare la somministrazione di glucagone.
Fonte: Manuale di anestesia e rianimazione. Concorso Nazionale SSM.